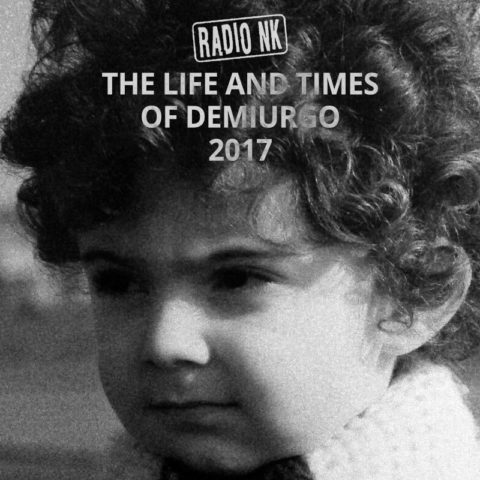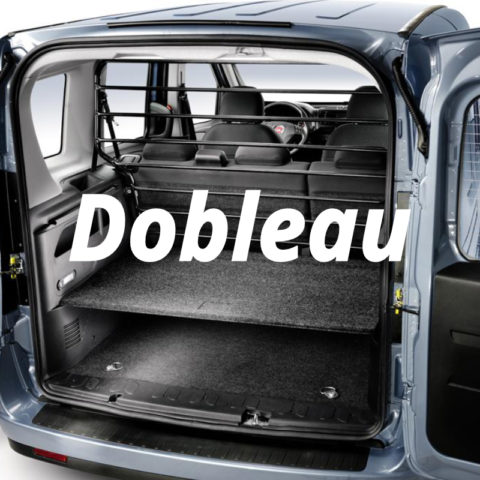Venerdì 26 agosto 2011, alle ore 13.51
Fluttuavo acerbo in una bottiglia di liquido salmastro, negandomi alla finzione, negandomi al gesto didascalico dell’ apparire che chiunque oramai ti implora di onorare. Ero molle, ero un bulbo trasparente scivolato via da un altro oggetto che a sua volta era il frutto acerbo di un’altra creatura immateriale, forse dell’abisso stesso. Ero l’impazienza del fenomeno che non resiste alla pressione dell’attimo che passa. Davanti a me c’erano solo flutti incomprensibili e un orizzonte verde oltre il quale bruciavano fiammeggiando gli idoli, precipitati da quel mondo incivile che crediamo di usare come scudo e che invece si fa scudo di noi per le sue battaglie insensate. Il sole del sabato pomeriggio, le gomme che calpestano il selciato, le unghie, i tubi colorati da cui cola un caleidoscopio dolce ed appiccicoso di unguenti in cui vorrei affogare, le nuvole violastre, tutto sembra vecchio e conosciuto. Lo posso annusare, lo posso toccare, posso sentirne la superficie madida. Riscuotimi. Afferra le mie maniglie curvilinee, prova a guardarmi dentro, come per cercare il lato giusto da usare. Dondolami, fammi roteare, turbinami, rendimi tifone nella foresta, vedi come in un attimo si aprono voragini, si plasmano le rocce, si fondono i cristalli, sgorgano fiumi; trasciniamoci, lasciamo scie di verde, di azzurro, di giallo tutt’attorno. Strizzami, lascia che scrosci acqueo, lascia che piova addosso a tutto, divertiti a creare rivoli, sorridi guardando tutto ciò che prima era polvere e ghiaia e sabbia sciogliersi in brillante liquido; trasportami, stupisciti nell’accorgerti che sotto tutto scorre, e che con un gesto tutto diventa veloce e mutevole, percepisci il rombo di migliaia, di milioni di gesti identici e rimani attonita mentre tutto si trasforma in scie di luce bianchissima. Incanalami, forzami dentro un condotto da cui uscirò sotto forma di lunghissimo cilindro, forzami ad assumere forme geometriche sempre più complicate, attorcigliami, appiattiscimi, rendimi geometrico. No. Semplifichiamoci, lasciamoci tradurre, lasciamoci descrivere con parole comprensibili anche ai profani, anche agli incolti. Ciò che è concetto indescrivibile diventi numero complesso, e poi semplice fonema, e poi colore primario, ed infine sensazione primitiva. Emettiamoci, moduliamoci, cresciamo a poco a poco dentro e poi facciamoci urlare nelle brughiere sterminate, negli anfiteatri deserti, nei canaloni, nelle strade indemoniate di traffico. Squassiamoci, sbricioliamoci, facciamoci ridurre fino ai costituenti stessi della materia. Gonfiamoci ed esplodiamo come bolle, mescoliamoci come nuvole, scrosciamo come cascate, tracimiamo come torrenti, spiaggiamoci come relitti, schizziamo come fanghiglia, crepitiamo come tizzoni, secchiamoci come terra riarsa, saturiamoci, facciamoci ricoprire di numerosi strati di materiali simili, scuciamoci, slabbriamoci, lasciamo fuoriuscire l’imbottitura che abbiamo dentro. Vibriamo, diventiamo onde, variazioni di campi nello spazio, fenomeni fisici spiegabili con formule algebriche; rendiamoci altri, trasfiguriamoci, trasformiamoci, diventiamo stoffa, luce, lamina metallica, bolla di gas, roccia ignea, recipiente plastico, altra creatura pensante, migliore della somma delle parti.
E, mentre pensavo questo, mi accorsi che mi fissava.
La troia.